Nietzsche e la decadenza del
mondo occidentale
Nella
sua opera giovanile “La nascita della tragedia” Nietzsche affronta il problema
di come è nata la tragedia greca e dice che per comprendere bene il genio dei
greci bisogna fare riferimento a due dimensioni o categorie, quella
dell’Apollineo e quella del Dionisiaco.
Prosegue affermando che l'errore della
specie umana consiste proprio nell'aver voluto trovare un perchè ad ogni cosa,
nel tentativo di razionalizzare tutto, facendo morire il senso del tragico
presente fino ad Eschilo e a Sofocle, massimi esponenti della tragedia greca.
E' a partire da Euripide che si é avviato questo esasperato processo di
razionalizzazione che ha portato in trionfo il dio Apollo, il solare dio della
razionalità, a discapito di Diòniso, il notturno Dio dei festini e della
tragedia.
Quella
dell’Apollineo (del dio Apollo) incarna la forma, il finito, la ragione e che
sostanzialmente era caratterizzato dalla scultura e dalla poesia epica ed era
ben equilibrato da un altro spirito, quello Dionisiaco che scaturisce dalla
forza vitale, è caos, è divenire, è l’ebrezza, è la danza del dio Diòniso.
Finché queste due dimensioni stavano in equilibrio il mondo greco ha prodotto
le tragedie classiche di Sofocle di Eschilo, ecc. (la tragedia attica), solo
che poi ha prevalso l’Apollineo, cioè la ragione ha prevalso sulla vita e sul
divenire, quando la ragione ha cercato di dare un senso alla vita. Nietzsche si
richiama a Socrate e alla tragedia di Euripide che si rifà a Socrate.
Nietzsche
fa questa sottolineatura, il coro nella tragedia antica partecipava alla
rappresentazione in un circolo vitale, con la tragedia di Euripide il coro invece
commenta quello che accade al protagonista e cerca di darne un senso. Questo
prevalere della ragione e del senso della vita è per Nietzsche il primo segnale
della decadenza del mondo occidentale. L’uomo cioè ha creato un rimedio alla
vita facendo emergere la verità, l’immutabile, il senso, la ragione.
Quindi
la filosofia non nasce per la meraviglia che affascina gli uomini che scoprono
la realtà e la vita, ma dall’orrore che invece scoprono studiando la vita e la
realtà, allo sgomento di fronte al divenire inesorabile e caotico della vita.
L’uomo allora pone rimedio a questa paura che lo attanaglia “ragionando”
(filosofeggiando). Infatti il greco thauma usato da Aristotele significa
sì meraviglia e stupore, ma anche dovuto alla paura e al terrore del divenire.
Di
fronte a questa nuova prospettiva deve nascere una nuova umanità. Il famoso
“superuomo”. Diciamo subito che il filosofo nostro contemporaneo Gianni
Vattimo, suggerisce di chiamarlo “oltre-uomo” per non confonderlo con Superman
o Flash Gordon.
Il “superuomo” di Nietzsche
non è un uomo più potente di tutti e con poteri superiori e straordinari, ma un
uomo che vada oltre il concetto di uomo, quello che per due millenni è rimasto
schiacciato da ideologie e menzogne che lo hanno tenuto lontano dalla sua vera
vita.
Zarathustra e l’oltre-uomo
Questo
concetto di “super uomo” o di “oltre-uomo” proviene dalla famosa opera di
Nietzsche “Così parlò Zarathustra” . Zarathustra o Zoroastro è un profeta
indiano vissuto intorno al 1.600 a.C. a cui la tradizione attribuisce
l’invenzione della religione zoroathrista. Nietzsche attribuisce a questo
personaggio l’annuncio del suo “oltre-uomo”.
L’oltre-uomo
è un uomo che sopravvive alla notizia della morte di Dio. Cioè l’uomo che
capisce che è morto qualunque senso o direzione o meta che si voglia dare alla
vita, sia metafisica che immanente. Nella “Gaia Scienza” Nietzsche afferma la
necessità di non sostituire Dio con qualcos’altro, feticci o alternative a Dio.
Di non riempire il vuoto lasciato da Dio con qualche altra divinità.
La vera grande battaglia che Nietzsche porta avanti é contro
Dio: credere in un Dio che punisce e in un mondo ultraterreno non fa altro che
rimpicciolire l'uomo e fargli perdere il senso della terra! "Dopo che
Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una
caverna, un'immensa orribile ombra. Dio é morto: ma stando alla natura degli uomini,
ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua
ombra. E noi, noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!".
Molti
hanno cercato e molti in futuro cercheranno di trovare un senso razionale
alla
vita, chiedendosi il perchè e provando a trovare una spiegazione. Ma la cosa
più importante é imparare ad apprezzare la vita, senza mai perdere il senso
della terra, annebbiati da eventuali vite ultraterrene! Chiunque vi da speranze
ultraterrene (l’illuminismo, la scienza, Il marxismo, il progresso, il sol
dell’avvenire, il paradiso, ecc.) fa il vostro male, vi illude. La storia (non)
marcia verso nessuna direzione.
Le tre metamorfosi
“Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito
diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone fanciullo”.
Cioè lo spirito umano è stato per secoli cammello
(schiacciato da due gobbe – due millenni di menzogne). Quando poi il cammello
diventa leone, quando cioè si accorge delle millenarie menzogne, l’uomo si
libera dai fardelli metafisici all’insegna del “io voglio” me, nell’ambito di
una realtà ancora negativa che non gli permette ancora di essere ciò che è.
Infine il leone diventa fanciullo, cioè sta nascendo un nuovo tipo di uomo. Quindi
il nuovo uomo nasce sapendo che Dio è morto, che rimane morto e che nemmeno la
sua ombra o un suo surrogato può sostituirlo. L’uomo nuovo ora sa che tutto ciò
che è stato presentato come punto o cosa a cui tendere è sempre stato solo
menzogna, raggiro, veleno per la vita dell’uomo. L’uomo nuovo ha sconfitto due
millenni di menzogne.
Il dittatore logico Socrate ha bevuto la cicuta tutto
contento e sereno, ma Nietzsche afferma che come Apollo
ha dato un veleno mortale a Dioniso facendo prevalere la ragione sulla vita, su
divenire, sull’istinto, così Socrate ha bevuto la cicuta e l’ha fatta bere a
tutto l’occidente lasciando intendere che la vita è tutta una ricerca per
raggiungere una meta che non arriva mai e che fa dimenticare di vivere. Bisogna
restituire all’uomo la vita.
L’oltre uomo quindi è
colui che innanzitutto sopravvive alla notizia che Dio è morto e che resta
morto e non inventa un surrogato di Dio da mettere al suo posto. L’oltre-uomo
ha sconfitto millenni di menzogne, di illusioni, di falsità, di veleno. L’oltre-uomo
è questa creatura nuova che vive finalmente questa nuova condizione di sapere
che non c’è verità, non c’è Dio, non c’è direzione, non c’è meta, non c’è
senso.
Il pensiero dell’eterno ritorno dell’uguale
Ma l’oltre-uomo è anche
colui che fa suo un pensiero abissale: “il
pensiero dell’eterno ritorno dell’uguale”. È questa una sua dottrina che
afferma che tutto ciò che vediamo ritorna eternamente e che è contenuta nella
sua opera “La gaia scienza”.
L’Eterno Ritorno dell’Uguale, che è caposaldo della filosofia di Nietzsche,
è probabilmente caratteristica o archetipo
narrativo universale, è infine elemento che scandisce le nostre
esistenze. Ne siamo immersi, lo viviamo ogni giorno.
Ogni volta che ci mettiamo a cena, che stappiamo una bottiglia di vino, che brindiamo per un anniversario, che diamo da mangiare al gatto, che ci laviamo la faccia … ogni volta che ci svegliamo.Siamo prigionieri dell’Eterno Ritorno, poiché siamo strettamente legati, e parte integrante, di un sistema finito, immerso in un tempo infinito.
Ogni volta che ci mettiamo a cena, che stappiamo una bottiglia di vino, che brindiamo per un anniversario, che diamo da mangiare al gatto, che ci laviamo la faccia … ogni volta che ci svegliamo.Siamo prigionieri dell’Eterno Ritorno, poiché siamo strettamente legati, e parte integrante, di un sistema finito, immerso in un tempo infinito.
La gaia scienza, Libro
IV, n. 341 (estratto)
Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone
strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse:
«Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una
volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo,
ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente
piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella
stessa sequenza e successione - e così pure questo ragno e questo lume di luna
tra i rami e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra
dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello di
polvere!». Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il
demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo
immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei un dio e mai
intesi cosa più divina»? Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te,
quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; la
domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora
innumerevoli volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! Oppure,
quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più alcun'altra
cosa che questa ultima eterna sanzione, questo suggello?"
Friedrich Nietzsche ricupera qui la
visione ciclica del tempo (il circolo di Plotino) per combattere la visione
lineare del tempo del cristianesimo che aveva conquistato tutto l’occidente. Lo
stesso illuminismo, il marxismo, il positivismo, ecc. avevano utilizzato lo
stesso concetto di linearità del tempo e della storia, una linea retta che va
verso una direzione ben precisa e definita. Creazione del mondo e dell’uomo,
peccato originale, castigo di Adamo ed Eva, venuta di Gesù Cristo, sua passione
e morte e quindi resurrezione, salita al celo, nascita della Chiesa e attesa
del suo ritorno sulla terra e quindi Apocalisse (disvelamento finale). Gli stessi
negatori del cristianesimo, mai avevano combattuto questo concetto di
linearità, anzi lo avevano adottato in pieno. Cioè tutti avevano adottato il
criterio di un percorso che si svolge nel tempo per raggiungere una meta. La
vita è come una corsa verso una meta, ogni ideologia ha la sua: l’Apocalisse
per i cristiani, il sol dell’avvenire per il marxismo, o la scienza che risolve
tutto, o la libertà piena, ecc. Nietzsche invece scardina completamente l’idea
di tempo, la storia (non) va verso nessuna direzione, non va da nessuna parte,
non va verso nessuna meta. La visione ciclica serve a Nietzsche per dire che
solo in una visione ciclica del tempo ci fa dire si alla vita. Ci vuole un uomo
nuovo per accettare l’idea che tutto ritorna. Solo così l’uomo ama la vita, non
una sola volta, ma infinite volte, nel dolore e nel piacere. L’oltre-uomo è
colui che accetta tutto quello che la vita dà (il bello e il brutto, la gioia e
la sofferenza, il benessere e il malessere). Il nuovo uomo è quello che ce la
fa a dire si alla vita e a tutto ciò che in essa accade, a volere la vita fino
in fondo e per sempre e in tutte le sue manifestazioni. L’oltre uomo è colui
che accetta il divenire, che accetta la vita e tutto ciò che la vita da. Sta
qui la differenza fra Nietzsche e
Schopenhauer.
Nietzsche e Schopenhauer
Nietzsche all’inizio fu un
entusiasta del mondo come “volontà e rappresentazione” prospettato da Schopenhauer. La filosofia di
Schopenhauer, come abbiamo visto , contiene nella sua opera giovanile, gran
parte del suo pensiero, espresso in “ Il
mondo come volontà e rappresentazione” , Schopenhauer sostiene che il mondo
è fondamentalmente ciò che ciascun uomo vede ("relativismo") tramite
la sua volontà, nella quale
consiste il principio assoluto della
realtà, nascosto alla ragione. La
sua analisi pessimistica lo porta alla conclusione che i desideri emotivi,
fisici e sessuali, che presto perdono ogni piacere dopo essere stati
assecondati, ed infine divengono insufficienti per una piena felicità, non potranno
mai essere pienamente soddisfatti e quindi andrebbero limitati, se si vuole
vivere sereni. La condizione umana è completamente insoddisfacente, in ultima
analisi, e quindi estremamente dolorosa.
Di conseguenza, egli ritiene che uno stile di vita che
voglia negare i desideri, e che sia del tutto simile agli insegnamenti ascetici dei Vedanta e delle Upanishad dell'induismo, del Buddhismo delle origini, e dei Padri della Chiesa del primo Cristianesimo, nonché una morale della compassione, è quindi l'unico vero
modo, anche se difficile per lo stesso filosofo, per raggiungere la liberazione
definitiva, in questa vita o nelle
successive. Sull'esistenza di Dio, Schopenhauer è invece ateo, almeno per quanto riguarda la
concezione occidentale moderna. Schopenhauer non si contrappone all’idea che
Dio è morto, è d’accordo con il concetto che la vita è volontà senza senso, che
tutto ciò che è reale è razionale, l’essenza del mondo è una volontà di vita
che procede inesorabilmente, senza senso, senza scopo, senza direzione, una
volontà cieca e irrazionale.
Il giovane Nietzsche quando legge
Schopenhauer ne è entusiasta, ma poi rimane deluso dal constatare che
Schopenhauer proponeva poi una cura: l’arte, la pietà, ma soprattutto l’ascesi.
In questo “farmaco” per affrontare la vita, Nietzsche ci vede un modo per tagliare i ponti con la vera vita.
Schopenhauer che concorda con l’idea che la vita è senza meta e senza senso, poi
di fatto propone un rimedio che dice no alla vita.
Dalla “voluntas” alla “noluntas”.
In particolare l’ascesi proposta è un vero e proprio distaccarsi dalla vita.
Nietzsche dice no a questo
rimedio, la vita va accolta, non ci sono cure, altrimenti gli diamo la cicuta
di Socrate o la cicuta dell’ascesi di Schopenhauer o la cicuta del regno dei
celi dei cristiani o del mondo delle idee di Platone: basta insegnarci a
morire, vogliamo vivere. Basta con la filosofia che pretende di darci la cura
per la vita. Cura che in realtà non è tale perché ci fa morire. Basta con il
marxismo che ci fa morire con il concetto che l’individuo umano deve
sacrificarsi per la collettività e che è un essere genericamente determinato e
quindi immortale. Basta con il positivismo che ci pone come meta il progresso
scientifico, ma per arrivare a cosa?
Nietzsche lancia un appello “vi scongiuro, rimanete fedeli alla
terra”, cioè diamo un si incondizionato alla vita, con tutto quello che essa
comporta, una vita che tornerà un numero innumerevole di volte.
La visione e l’enigma
Il
brano di Così parlò Zarathustra che per primo annuncia l’eterno ritorno
è La visione e l’enigma. La dottrina dell’eterno ritorno viene qui
esposta mediante una “visione” enigmatica, essa è «la visione del più solitario tra gli uomini (lo stesso
Nietzsche)». L’eterno ritorno
richiede una solitudine assoluta, e questo perché necessita di una
trasformazione nell’intimo dell’uomo. La visione descrive Zarathustra che si
inoltra in un sentiero desolante ed in salita: «Un sentiero, in salita dispettosa
tra sfasciume di pietre: un sentiero di montagna digrignava sotto il dispetto
del mio piede (simbolo del faticoso innalzarsi del pensiero. Il cammino di
Zarathustra è in salita ed il suo incedere è reso faticoso da una presenza: lo
spirito di gravità. Questo spirito è rappresentato da un nano a lui
aggrappato che vuole vanificare ogni superamento, ogni anelare dell’uomo a
qualcosa di superiore.
Zarathustra
però non si arrende, il suo spirito è pieno di coraggio: «Alt, nano! dissi. O
io! O tu! Ma di noi due il più forte son io –: tu non conosci il mio pensiero
abissale! Questo– tu non potresti sopportarlo!». Solo quindi questo
«pensiero abissale» può sconfiggere lo spirito di gravità. Ed infatti
pronunziate queste parole: «avvenne qualcosa che mi rese più leggero: il nano
infatti mi saltò giù dalle spalle, incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su
di un sasso. Ma, proprio dove ci eravamo fermati, era una porta carraia». Da
qui prende inizio la descrizione del punto nevralgico della visione dell’eterno
ritorno. Seguiamo punto per punto i passi di questa visione: «Garda questa
porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui:
nessuno li ha mai percorsi fino alla fine». La porta carraia, per sua natura, è
un punto di sutura, unisce due vie. Le due vie simbolizzano le due estasi del
tempo, il passato e il futuro; entrambe infinite, e quindi impercorribili fino
in fondo, l’una si contrappone all’altra: «Si contraddicono a vicenda, questi
sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a questa porta carraia,
essi convergono. In alto sta scritto il nome della porta “attimo”». Il tempo,
se visto come un flusso continuo, si presenta come una linea continua ed infinita;
se visto invece a partire dall’“attimo”, le due infinità del tempo sono tra
loro sia convergenti sia divergenti. L’attimo cioè è il punto a partire dal
quale le due infinità si approssimano, ma anche si allontanano. L’attimo crea
quindi una estrema tensione tra le due infinità; «ma chi ne percorresse uno dei
due – sempre più avanti e sempre più lontano: credi tu, nano, che questi
sentieri si contraddicano in eterno?». Il punto essenziale è quindi capire se
questa tensione nell’eternità del tempo venga risolta, oppure no.
Bisogna
subito ribadire che l’eterno ritorno non è la semplice affermazione che il
tempo è in verità circolare. Infatti, il nano semplifica la descrizione di
Zarathustra: «Tutte le cose dritte
mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo
stesso è circolo. Le cose diritte sono una parvenza. In verità il loro scorrere
è un circolo, cioè la verità stessa – l’ente, così come esso in verità scorre –
è ricurvo. Il ruotare-in-circolo-su-se-stesso del tempo e quindi il continuo
ritornare dell’uguale, di tutti gli enti, nel tempo, è il modo in cui l’ente
nel suo insieme è. Esso è il modo dell’eterno ritorno. Così il nano è giunto a
indovinare l’enigma».
Ma
Zarathustra rimprovera il nano, accusandolo di prendere questo enigma troppo
alla leggera: «Tu, spirito di gravità! dissi io incollerito, non prendere la
cosa troppo alla leggera! O ti lascio accovacciato dove ti trovi, sciancato – e
sono io che ti ho portato in alto!». La questione dell’eterno
ritorno posta come semplice circolarità del tempo, è per Zarathustra
estremamente semplificante, non coglie, cioè, il punto essenziale di questa
dottrina. Vediamo come invece Zarathustra pone l’essenza dell’eterno ritorno:
«Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta carraia che si chiama
attimo, comincia all’indietro una via lunga, eterna: dietro di
noi è un’eternità.
Lo
scenario precedente svanisce; d’un tratto Zarathustra si trova «in mezzo a
orridi macigni, solo, desolato, al più desolato dei chiari di luna». E nelle
prossimità di un cane che ululava, vide una scena agghiacciante: «Vidi un
giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve
serpente nero penzolava dalla bocca». Cosa simbolizza il giovane pastore e il
serpente? Il giovane pastore è Zarathustra stesso, mentre il serpente simbolizza
la circolarità dell’eterno ritorno. Ma allora perché Zarathustra è
drammaticamente aggiogato dal pensiero che più di tutti dovrebbe invece
affrancarlo?
In
effetti, l’eterno ritorno ha due differenti letture, l’una delle quali
atterrisce Zarathustra. Se infatti l’eterno ritorno mostra che tutti gli
accadimenti dovranno in eterno ripetersi, allora la volontà che crea, in
verità, non crea nulla di nuovo, perché appunto ciò che di nuovo crea è già
stato creato, e non una volta, ma infinite volte. Da questo punto di vista
l’eterno ritorno porta all’estremo la sofferenza della verità metafisica; in
quanto appunto, come la verità trascendente, l’eterno ritorno, aggioga l’uomo
ad una legge eterna.
Ma
esiste anche un’altra lettura dell’eterno ritorno, quella per cui ogni nostro
decidere, ogni nostra scelta, è una novità assoluta che si eternizza; nel senso
che ogni nostro superamento non si esaurisce nel tempo della vita attuale,
come vorrebbe lo spirito di gravità, ma eternamente ritorna. Eterno è ogni
nostro attimo, e quindi eterna è ogni nostra opera, ogni nostro creare; non
perché già da sempre ritornante, ma perché il nostro creare crea un frammento
dell’eternità. Il tutto insomma si gioca su come intendiamo l’“attimo”,
se l’interpretiamo mediante il primo senso negativo dell’eterno ritorno, allora
l’attimo non è altro che il ripetersi eternamente di qualcosa di già deciso, e
di cui la nostra volontà non può far nulla; se invece interpretiamo l’attimo
mediante il secondo senso positivo dell’eterno ritorno, allora esso è veramente
un atto creativo “nuovo” che ritornerà in eterno, o anche qualcosa che io già
da sempre ho creato e per sempre ritornerà.
Ed
infatti, nella visione Zarathustra prova all’inizio a strappare il serpente
dalle fauci del giovane pastore, ma non riuscendoci, grida «Mordi! Mordi!
Staccagli il capo! Mordi!». Il morso non è altro che l’attimo deciso dall’uomo che si eternizza per
sempre. Infatti, il pastore che mordendo stacca la testa del serpente si
trasforma: «Non più pastore, non più uomo, – un trasformato, un circonfuso di
luce, che rideva! Mai prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise!».
È il riso del fanciullo eracliteo che in un attimo crea una nuova eterna
configurazione del mondo. È l’oltre-uomo.
Dunque
abbiamo visto chi è questo “superuomo” di Nietzsche che abbiamo ribattezzato
“oltre-uomo”. È un uomo che sopravvive all’idea della morte di Dio, fa sua
l’idea abissale dell’eterno ritorno. Ma c’è dell’altro è anche l’uomo che attua
la transvalutazione di tutti i valori.
La transvalutazione di tutti i valori.
Se
cioè tutte quello che è stato pensato fino ad ora è falso, se tutto quello che
è stato creduto è addirittura deleterio, anzi velenoso perché non cura l’uomo
ma lo uccide, è chiaro allora che tutti i valori etici e morali, tutto ciò a
cui è stato attribuito valore, in realtà è un disvalore. Bisogna allora attuare
una transvalutazione di valori, cioè trasformare la valutazione che diamo dei
valori. L’oltre-uomo è colui che vede e valuta la vita in un altro modo, colui
che abbraccia i valori vitali e non quelli disumani. Nella sua opera “la genealogia della morale” ricerca
l’origine dei valori e afferma che nell’antica Grecia c’era un equilibrio fra
la casta dei guerrieri che detenevano il potere con il coraggio e la forza e
quella dei Sacerdoti che portavano i valori morali e spirituali. Ad un certo
punto però prevalse la casta dei sacerdoti, come avvenne con gli ebrei e poi
con i cristiani, e furono poi questi a definire quali fossero i veri valori da
seguire. Nasce così la morale occidentale a seguito di una sorta di rivalsa dei
sacerdoti (fisicamente più deboli e meno eroici) sui guerrieri più legati alle vere forze vitali
dell’uomo.
I
sacerdoti sono così riusciti a far prevalere quei valori che sono di fatto
contro la vita, contro la forza e contro il corpo.
“Sono
stati gli ebrei ad aver osato con una terrificante consequenzialità, stringendolo
ben saldo con i denti dell’odio più abissale, l’odio dell’impotenza, il
rovesciamento della aristocratica equazione di valore: buono, nobile, potente,
bello, felice, caro agli dei. Definendo invece come buoni soltanto i miserabili,
i poveri, gli impotenti, gli umili, i sofferenti, gli indigenti, i sofferenti,
i deformi e quelli che di fatto sono gli unici devoti. Sono stati cioè
valorizzati solo i valori antivitali. Sono stati posti come esempio da imitare
le categorie più deboli. Per Nietzsche l’oltre-uomo è un aristocratico,
appartenente ad una casta limitata dei veri forti, di coloro che amano la vita,
la purezza della vita, contro tutti coloro che invece esaltano la non vita.
L’oltre-uomo non è una proposta per tutta l’umanità, ma per una casta
aristocratica illuminata.
Il
cristianesimo non ha fatto altro che questi disvalori ebraici diventassero
patrimonio dell’umanità. Il cristianesimo ha sconfitto la grande Roma, simbolo
della potenza, dell’eroismo, della forza. Quando la gente comincia ad esaltare
valori antivitali gli uomini forti e coraggiosi crollano. Già la parola
cristianesimo è per Nietzsche un equivoco. È esistito un solo cristiano e
questi è morto crocifisso.
Nietzsche
infatti ha simpatia per Cristo, ma odia i cristiani perché mentre Cristo ha
detto il suo si alla vita accettando la morte e la morte di croce, i cristiani
cercando di imitarlo dicono no alla vita. Non esiste la verità, esiste la
prospettiva che ognuno dà alla propria vita.
La volontà di potenza
Nietzsche se la prende anche con il
positivismo. Non esistono i fatti, ma la personale interpretazione dei fatti di
ciascuno.
La
volontà di potenza e di dominio spiegata da Nicola Abbagnano ( 1901–1990 - filosofo e storico ateo della
filosofia italiano)
“La
volontà di potenza di cui parla Nietzsche non ha solo le valenze teoriche già
descritte, ma ne contiene anche altre ben più crude e storicamente funeste come
la sopraffazione e il dominio. La vita è essenzialmente appropriazione, offesa,
sopraffazione di tutto quanto è estraneo e più debole, bisogna sopraffare il
debole perché è una minaccia per la vita. La lotta per l’uguaglianza dei
diritti è già un sintomo di malattia, perché salvare il sano e insieme
all’ammalto è una contaminazione della razza pura. Di fronte a testi
inequivocabili di questo tipo che avevano già impressionato Lucas e che nessun
successivo esorcismo interpretativo è riuscito a minimizzare o a edulcorare,
non si può fare a meno di riconoscere che nella visione di Nietzsche della
volontà di potenza albergano aspetti antidemocratici e antiegualitari che fanno
parte della componente reazionaria del suo pensiero”.
La filosofia di Nietzsche è una filosofia
per spiriti forti che si richiama a Eraclìto, aristocratico per eccellenza, con
i suoi “svegli” e i suoi “dormienti” e che è stata poi pienamente abbracciata
dal Nazismo.
Vita di Nietzsche
Friedrich Wilhelm Nietzsche ( Röcken 1844 – Weimar 1900
)
è stato un filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco, tra i massimi filosofi e
prosatori di ogni tempo, Nietzsche ebbe un'influenza controversa, ma
indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del Novecento. La sua filosofia,
appartenente al filone delle filosofie della vita, è
considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo
modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un
pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui
esercitata sul pensiero posteriore.
Nietzsche
scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in
particolare quella cristiana),
la società moderna, la scienza,
intrise di una profonda lucidità ed avversione alla metafisica,
seppure spesso il filosofo venga accomunato anche all'irrazionalismo,
di una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia,
portando anche l'occidente a conoscenza di parte delle filosofie orientali. Nella sua filosofia si distingue una fase
wagneriana, che comprende La Nascita
della Tragedia e
le Considerazioni
inattuali, in cui il filosofo
combatte a fianco di Wagner per
una riforma mitica della cultura tedesca.
Questa fase sarà poi
abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano - nella stagione cosiddetta
"illuministica" del suo pensiero -, per culminare infine,
pochi anni prima del crollo nervoso - probabile conseguenza di una patologia neurologica ereditaria - che metterà fine alla sua attività,
nella fase più prominente del suo pensiero (quella della trasvalutazione dei valori e del nichilismo
attivo, costellata
dai concetti di Oltreuomo, eterno
ritorno e volontà di potenza) che ha il suo apice ed
inizio con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra.
Commento di don Claudio Crescimanno
Dunque la realtà non ha senso, la
vita e la morte non hanno spiegazione e non hanno senso, non si può cercare
destinazione né al pensiero né all’azione, cioè non c’è un punto di arrivo nel
mio pensare e nel mio agire. Questo non senso non può essere attenuato, e tanto
meno risolto, dall’idea che esista qualche cosa fuori di me che possa dare quel
senso, quel significato, quello scopo che io non gli posso dare.
Nietzsche
infatti non dice tanto che Dio non c’è, ma fa molto di più, si batte per
togliere agli uomini l’illusione che ci sia un Dio o una divinità o un suo
surrogato o una sua idea o un suo luogotenente o altro a cui aggrapparsi per un
ingiustificabile bisogno di senso.
Non
è un caso che l’originatore di tutto questo sia Zaratustra, questo fantomatico
personaggio dell’antichità (circa 3.000 anni prima), dai contorni sfumati e
fondatore di una religione che ha queste caratteristiche, e quindi scelto da
Nietzsche proprio per questo. Ed è curioso che per far nascere un uomo nuovo
utilizzi un “profeta” così antico.
Lo
Zoroastrismo ha queste caratteristiche:
1.
è una religione
senza Dio, non è una
religione teologica, cioè non si pone domande su Dio, è una religione antropologica,
è un via per l’uomo, non un via per l’uomo verso Dio.
2.
è un satellite del
grande sistema manicheo, in cui il bene e il male sono sullo stesso piano e hanno una funzione
reciproca. È di fatto la visione dell’equilibrio fra l’Apollineo e il
Dionisiaco, tra la ragione e l’istinto, tra il bene e il male, tra la luce è
l’oscurità. Due Spiriti
primi sono il Bene e il Male, la Verità e la Menzogna: ai seguaci del primo
toccherà in sorte la Vita e la Migliore Esistenza mentre i seguaci del secondo
otterranno la Non-Vita e la Peggiore Esistenza.
3.
è la religione della
forza. In esso la casta dei sacerdoti è
la casta dei guerrieri. La casta che custodisce i segreti misterici ed
esoterici della religione e della vita è una casta di sacerdoti guerrieri o di
guerrieri sacerdoti.
Quindi
possiamo dire che lo Zoroastrismo
si prestava “ad hoc” allo scopo di Nietzsche e alla dimostrazione della sua tesi.
Ci
stiamo avvicinando alla fine di un percorso che ci vede nel secolo XIX° alla
morte di Nietzsche e alla vigilia della realizzazione sperimentale delle due
grandi correnti: la sinistra hegeliana con Marx e la destra razzista di
Nietzsche accomunate, anche se nemiche, dal rifiuto di Dio e dall’uso della
forza delle idee e delle armi.
Siamo
cioè alla vigilia della realizzazione pratica di queste due correnti di
pensiero. Abbiamo già evidenziato che i filosofi non sono dei teorici astratti
che lasciano il tempo che trovano, ma influenzano gli uomini, le loro passioni,
le loro strutture e istituzioni e le loro azioni.
La
famosa frase “La filosofia è quella cosa con la quale e senza la quale il mondo
rimane tale e quale” che ricorre quasi sempre quando si inizia a studiare
filosofia a scuola vorrebbe essere un invito per i “dormienti” a lasciarla
perdere per dare agli “svegli” la possibilità di dominarli [Ndr].
Da
questi due pensatori, Marx e Nietzsche, sono venuti i due grandi sistemi che
hanno imperversato e ancora imperversano anche con nuove forme di violenza i
nostri giorni.
Il
XX° secolo è dal punto di vista politico e culturale e per il suo esagerato
contributo di sangue, la realizzazione di queste due ideologie (Marxismo e
Nazionalsocialismo) che non possiamo non chiamare demoniache perché utilizzate
a piene mani dal seduttore di sempre che cerca di realizzare l’inferno già su
questa terra [Ndr].
Il
pensiero di Nietzsche comunque è un pensiero poderoso, è la prima grande novità
dopo tanta rimasticatura dell’idea illuministica e idealista che ha
imperversato per due secoli. Dal punto di vista storico però prende un abbaglio
impressionante.
Di
fatto anche Nietzsche fonda una sua religione, critica gli altri perché si
creano un dio con la D minuscola che sostituisce la Classe, la Scienza, la
Ragione, ecc. ma di fatto lo fa anche lui, perché se non fosse che deve
sostenere una tesi ed avere una visione ideologica della realtà, non potrebbe
non rendersi conto dell’abbaglio storico che ha preso. Nietzsche infatti
sostiene che la religione biblica ebraico cristiana, cioè il sistema di idee
più importante e influente in tutto l’occidente, a da qui in tutto il mondo, è
stato un fattore paralizzante della vita.
Storicamente
invece la religione biblica ebraico cristiana ha cosparso l’Europa e per
contagio il resto del mondo, di terreni bonificati (e relative tecniche), di
libri e culture salvati, di macchinari e tecniche cha hanno dato sviluppi
interessanti all’agricoltura, all’artigianato e alle industrie, di Scuole, di
Università e di Ospedali. Mentre la sua visione e quella del suo amico Marx
hanno riempito l’Europa di Gulag, di campi di concentramento, di processi
sommari, di olocausti, di purghe, di deportazioni, di pulizie etniche, di devastazioni
culturali, economiche, politiche, religiose, ecc.
Quale
visione è veramente contro la vita?
La gaia scienza,
Libro IV, n. 341 (estratto)
Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone
strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse:
«Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una
volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo,
ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni
indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te,
e tutte nella stessa sequenza e successione - e così pure questo ragno e
questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso.
L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con
essa, granello di polvere!». Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti
e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una
volta un attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei
un dio e mai intesi cosa più divina»? Se quel pensiero ti prendesse in suo
potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe;
la domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora
innumerevoli volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più grande!
Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più
alcun'altra cosa che questa ultima eterna sanzione, questo suggello?"
Friedrich Nietzsche ricupera qui
la visione ciclica del tempo (il circolo di Plotino) per combattere la
visione lineare del tempo del cristianesimo che aveva conquistato tutto
l’occidente. Lo stesso illuminismo, il marxismo, il positivismo, ecc. avevano
utilizzato lo stesso concetto di linearità del tempo e della storia, una
linea retta che va verso una direzione ben precisa e definita. Creazione del
mondo e dell’uomo, peccato originale, castigo di Adamo ed Eva, venuta di Gesù
Cristo, sua passione e morte e quindi resurrezione, salita al celo, nascita
della Chiesa e attesa del suo ritorno sulla terra e quindi Apocalisse (disvelamento finale). Gli
stessi negatori del cristianesimo, mai avevano combattuto questo concetto di
linearità, anzi lo avevano adottato in pieno. Cioè tutti avevano adottato il
criterio di un percorso che si svolge nel tempo per raggiungere una meta. La
vita è come una corsa verso una meta, ogni ideologia ha la sua: l’Apocalisse
per i cristiani, il sol dell’avvenire per il marxismo, o la scienza che
risolve tutto, o la libertà piena, ecc. Nietzsche invece scardina
completamente l’idea di tempo, la storia (non) va verso nessuna direzione,
non va da nessuna parte, non va verso nessuna meta. La visione ciclica serve
a Nietzsche per dire che solo in una visione ciclica del tempo ci fa dire si
alla vita. Ci vuole un uomo nuovo per accettare l’idea che tutto ritorna.
Solo così l’uomo ama la vita, non una sola volta, ma infinite volte, nel
dolore e nel piacere. L’oltre-uomo è colui che accetta tutto quello che la
vita dà (il bello e il brutto, la gioia e la sofferenza, il benessere e il
malessere). Il nuovo uomo è quello che ce la fa a dire si alla vita e a tutto
ciò che in essa accade, a volere la vita fino in fondo e per sempre e in
tutte le sue manifestazioni. L’oltre uomo è colui che accetta il divenire,
che accetta la vita e tutto ciò che la vita da. Sta qui la differenza fra
Nietzsche e Schopenhauer.
Nietzsche e Schopenhauer
Nietzsche all’inizio fu un
entusiasta del mondo come “volontà e rappresentazione” prospettato da Schopenhauer. La filosofia di
Schopenhauer, come abbiamo visto , contiene nella sua opera giovanile, gran
parte del suo pensiero, espresso in “ Il
mondo come volontà e rappresentazione” , Schopenhauer sostiene che il
mondo è fondamentalmente ciò che ciascun uomo vede ("relativismo")
tramite la sua volontà, nella
quale consiste il principio assoluto della
realtà, nascosto alla ragione. La
sua analisi pessimistica lo porta alla conclusione che i desideri emotivi,
fisici e sessuali, che presto perdono ogni piacere dopo essere stati
assecondati, ed infine divengono insufficienti per una piena felicità, non
potranno mai essere pienamente soddisfatti e quindi andrebbero limitati, se
si vuole vivere sereni. La condizione umana è completamente insoddisfacente,
in ultima analisi, e quindi estremamente dolorosa.
Di conseguenza, egli ritiene che uno stile di vita
che voglia negare i desideri, e che sia del tutto simile agli insegnamenti ascetici dei Vedanta e delle Upanishad dell'induismo, del Buddhismo delle origini, e dei Padri della Chiesa del primo Cristianesimo, nonché una morale
della compassione, è quindi
l'unico vero modo, anche se difficile per lo stesso filosofo, per raggiungere
la liberazione definitiva, in questa vita o nelle
successive. Sull'esistenza di Dio, Schopenhauer è invece ateo, almeno per quanto riguarda la
concezione occidentale moderna. Schopenhauer non si contrappone all’idea che
Dio è morto, è d’accordo con il concetto che la vita è volontà senza senso,
che tutto ciò che è reale è razionale, l’essenza del mondo è una volontà di
vita che procede inesorabilmente, senza senso, senza scopo, senza direzione,
una volontà cieca e irrazionale.
Nietzsche
dice no a questo rimedio, la vita va accolta, non ci sono cure, altrimenti
gli diamo la cicuta di Socrate o la cicuta dell’ascesi di Schopenhauer o la
cicuta del regno dei celi dei cristiani o del mondo delle idee di Platone:
basta insegnarci a morire, vogliamo vivere. Basta con la filosofia che
pretende di darci la cura per la vita. Cura che in realtà non è tale perché
ci fa morire. Basta con il marxismo che ci fa morire con il concetto che
l’individuo umano deve sacrificarsi per la collettività e che è un essere genericamente
determinato e quindi immortale. Basta con il positivismo che ci pone come
meta il progresso scientifico, ma per arrivare a cosa?
Nietzsche lancia un appello “vi scongiuro,
rimanete fedeli alla terra”, cioè diamo un si incondizionato alla vita, con
tutto quello che essa comporta, una vita che tornerà un numero innumerevole
di volte.
La visione e l’enigma
Il brano di Così parlò Zarathustra che per primo
annuncia l’eterno ritorno è La visione e l’enigma. La dottrina
dell’eterno ritorno viene qui esposta mediante una “visione” enigmatica, essa
è «la visione del più solitario tra
gli uomini (lo stesso Nietzsche)».
L’eterno ritorno richiede una solitudine assoluta, e questo perché necessita
di una trasformazione nell’intimo dell’uomo. La visione descrive Zarathustra
che si inoltra in un sentiero desolante ed in salita: «Un sentiero, in salita
dispettosa tra sfasciume di pietre: un sentiero di montagna digrignava sotto
il dispetto del mio piede (simbolo del faticoso innalzarsi del pensiero. Il
cammino di Zarathustra è in salita ed il suo incedere è reso faticoso da una
presenza: lo spirito di gravità.
Zarathustra però non si arrende, il suo spirito è pieno di
coraggio: «Alt, nano! dissi. O io! O tu! Ma di noi due il più forte son io –:
tu non conosci il mio pensiero abissale! Questo– tu non potresti
sopportarlo!». Solo quindi questo «pensiero abissale» può sconfiggere lo
spirito di gravità. Ed infatti pronunziate queste parole: «avvenne qualcosa
che mi rese più leggero: il nano infatti mi saltò giù dalle spalle,
incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su di un sasso. Ma, proprio dove ci
eravamo fermati, era una porta carraia». Da qui prende inizio la descrizione
del punto nevralgico della visione dell’eterno ritorno. Seguiamo punto per
punto i passi di questa visione: «Garda questa porta carraia! Nano!
continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: nessuno li ha mai
percorsi fino alla fine». La porta carraia, per sua natura, è un punto di
sutura, unisce due vie. Le due vie simbolizzano le due estasi del tempo, il
passato e il futuro; entrambe infinite, e quindi impercorribili fino in
fondo, l’una si contrappone all’altra: «Si contraddicono a vicenda, questi
sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a questa porta
carraia, essi convergono. In alto sta scritto il nome della porta “attimo”».
Il tempo, se visto come un flusso continuo, si presenta come una linea
continua ed infinita; se visto invece a partire dall’“attimo”, le due infinità
del tempo sono tra loro sia convergenti sia divergenti. L’attimo cioè è il
punto a partire dal quale le due infinità si approssimano, ma anche si
allontanano. L’attimo crea quindi una estrema tensione tra le due infinità;
«ma chi ne percorresse uno dei due – sempre più avanti e sempre più lontano:
credi tu, nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno?». Il punto
essenziale è quindi capire se questa tensione nell’eternità del tempo venga
risolta, oppure no.
Bisogna subito ribadire che l’eterno ritorno non è la
semplice affermazione che il tempo è in verità circolare. Infatti, il nano
semplifica la descrizione di Zarathustra: «Tutte le cose dritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni
verità è ricurva, il tempo stesso è circolo. Le cose diritte sono una
parvenza. In verità il loro scorrere è un circolo, cioè la verità stessa –
l’ente, così come esso in verità scorre – è ricurvo. Il
ruotare-in-circolo-su-se-stesso del tempo e quindi il continuo ritornare
dell’uguale, di tutti gli enti, nel tempo, è il modo in cui l’ente
nel suo insieme è. Esso è il modo dell’eterno ritorno. Così il nano è giunto
a indovinare l’enigma».
Ma Zarathustra rimprovera il nano, accusandolo di prendere
questo enigma troppo alla leggera: «Tu, spirito di gravità! dissi io
incollerito, non prendere la cosa troppo alla leggera! O ti lascio
accovacciato dove ti trovi, sciancato – e sono io che ti ho portato in alto!».
La questione dell’eterno ritorno posta come semplice circolarità del tempo, è
per Zarathustra estremamente semplificante, non coglie, cioè, il punto
essenziale di questa dottrina. Vediamo come invece Zarathustra pone l’essenza
dell’eterno ritorno: «Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta
carraia che si chiama attimo, comincia all’indietro una via
lunga, eterna: dietro di noi è un’eternità.
Lo scenario precedente svanisce; d’un tratto Zarathustra si
trova «in mezzo a orridi macigni, solo, desolato, al più desolato dei chiari
di luna». E nelle prossimità di un cane che ululava, vide una scena agghiacciante:
«Vidi un giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso,
cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca». Cosa simbolizza il giovane
pastore e il serpente? Il giovane pastore è Zarathustra stesso, mentre il
serpente simbolizza la circolarità dell’eterno ritorno. Ma allora perché
Zarathustra è drammaticamente aggiogato dal pensiero che più di tutti
dovrebbe invece affrancarlo?
In effetti, l’eterno ritorno ha due differenti letture,
l’una delle quali atterrisce Zarathustra. Se infatti l’eterno ritorno mostra
che tutti gli accadimenti dovranno in eterno ripetersi, allora la volontà che
crea, in verità, non crea nulla di nuovo, perché appunto ciò che di nuovo
crea è già stato creato, e non una volta, ma infinite volte. Da questo punto
di vista l’eterno ritorno porta all’estremo la sofferenza della verità
metafisica; in quanto appunto, come la verità trascendente, l’eterno ritorno,
aggioga l’uomo ad una legge eterna.
Ma esiste anche un’altra lettura dell’eterno ritorno,
quella per cui ogni nostro decidere, ogni nostra scelta, è una novità
assoluta che si eternizza; nel senso che ogni nostro superamento non si
esaurisce nel tempo della vita attuale, come vorrebbe lo spirito di gravità,
ma eternamente ritorna. Eterno è ogni nostro attimo, e quindi eterna è ogni
nostra opera, ogni nostro creare; non perché già da sempre ritornante, ma
perché il nostro creare crea un frammento dell’eternità. Il tutto insomma si
gioca su come intendiamo l’“attimo”, se l’interpretiamo mediante
il primo senso negativo dell’eterno ritorno, allora l’attimo non è altro che
il ripetersi eternamente di qualcosa di già deciso, e di cui la nostra
volontà non può far nulla; se invece interpretiamo l’attimo mediante il
secondo senso positivo dell’eterno ritorno, allora esso è veramente un atto
creativo “nuovo” che ritornerà in eterno, o anche qualcosa che io già da
sempre ho creato e per sempre ritornerà.
Ed infatti, nella visione Zarathustra prova all’inizio a
strappare il serpente dalle fauci del giovane pastore, ma non riuscendoci,
grida «Mordi! Mordi! Staccagli il capo! Mordi!». Il morso non è altro che
l’attimo deciso dall’uomo
che si eternizza per sempre. Infatti, il pastore che mordendo stacca la testa
del serpente si trasforma: «Non più pastore, non più uomo, – un trasformato,
un circonfuso di luce, che rideva! Mai prima al mondo aveva riso
un uomo, come lui rise!». È il riso del fanciullo eracliteo
che in un attimo crea una nuova eterna configurazione del mondo. È
l’oltre-uomo.
Dunque abbiamo visto chi è questo “superuomo” di Nietzsche
che abbiamo ribattezzato “oltre-uomo”. È un uomo che sopravvive all’idea
della morte di Dio, fa sua l’idea abissale dell’eterno ritorno. Ma c’è
dell’altro è anche l’uomo che attua la transvalutazione di tutti i valori.
La transvalutazione di tutti i valori.
Se cioè tutte quello che è stato pensato fino ad ora è
falso, se tutto quello che è stato creduto è addirittura deleterio, anzi
velenoso perché non cura l’uomo ma lo uccide, è chiaro allora che tutti i
valori etici e morali, tutto ciò a cui è stato attribuito valore, in realtà è
un disvalore. Bisogna allora attuare una transvalutazione di valori, cioè
trasformare la valutazione che diamo dei valori. L’oltre-uomo è colui che
vede e valuta la vita in un altro modo, colui che abbraccia i valori vitali e
non quelli disumani. Nella sua opera “la
genealogia della morale” ricerca l’origine dei valori e afferma che nell’antica
Grecia c’era un equilibrio fra la casta dei guerrieri che detenevano il
potere con il coraggio e la forza e quella dei Sacerdoti che portavano i valori
morali e spirituali. Ad un certo punto però prevalse la casta dei sacerdoti,
come avvenne con gli ebrei e poi con i cristiani, e furono poi questi a
definire quali fossero i veri valori da seguire. Nasce così la morale
occidentale a seguito di una sorta di rivalsa dei sacerdoti (fisicamente più
deboli e meno eroici) sui guerrieri
più legati alle vere forze vitali dell’uomo.
I sacerdoti sono così riusciti a far prevalere quei valori
che sono di fatto contro la vita, contro la forza e contro il corpo.
“Sono stati gli ebrei ad aver osato con una terrificante consequenzialità,
stringendolo ben saldo con i denti dell’odio più abissale, l’odio
dell’impotenza, il rovesciamento della aristocratica equazione di valore:
buono, nobile, potente, bello, felice, caro agli dei. Definendo invece come
buoni soltanto i miserabili, i poveri, gli impotenti, gli umili, i
sofferenti, gli indigenti, i sofferenti, i deformi e quelli che di fatto sono
gli unici devoti. Sono stati cioè valorizzati solo i valori antivitali. Sono
stati posti come esempio da imitare le categorie più deboli. Per Nietzsche
l’oltre-uomo è un aristocratico, appartenente ad una casta limitata dei veri
forti, di coloro che amano la vita, la purezza della vita, contro tutti
coloro che invece esaltano la non vita. L’oltre-uomo non è una proposta per
tutta l’umanità, ma per una casta aristocratica illuminata.
Il cristianesimo non ha fatto altro che questi disvalori ebraici
diventassero patrimonio dell’umanità. Il cristianesimo ha sconfitto la grande
Roma, simbolo della potenza, dell’eroismo, della forza. Quando la gente
comincia ad esaltare valori antivitali gli uomini forti e coraggiosi
crollano. Già la parola cristianesimo è per Nietzsche un equivoco. È esistito
un solo cristiano e questi è morto crocifisso.
Nietzsche infatti ha simpatia per Cristo, ma odia i
cristiani perché mentre Cristo ha detto il suo si alla vita accettando la
morte e la morte di croce, i cristiani cercando di imitarlo dicono no alla
vita. Non esiste la verità, esiste la prospettiva che ognuno dà alla propria
vita.
La volontà di potenza
Nietzsche se la prende anche con il
positivismo. Non esistono i fatti, ma la personale interpretazione dei fatti
di ciascuno.
La volontà di potenza e di dominio spiegata da Nicola Abbagnano ( 1901–1990 - filosofo e storico ateo
della filosofia italiano)
“La
volontà di potenza di cui parla Nietzsche non ha solo le valenze teoriche già
descritte, ma ne contiene anche altre ben più crude e storicamente funeste
come la sopraffazione e il dominio. La vita è essenzialmente appropriazione,
offesa, sopraffazione di tutto quanto è estraneo e più debole, bisogna
sopraffare il debole perché è una minaccia per la vita. La lotta per
l’uguaglianza dei diritti è già un sintomo di malattia, perché salvare il
sano e insieme all’ammalto è una contaminazione della razza pura. Di fronte a
testi inequivocabili di questo tipo che avevano già impressionato Lucas e che
nessun successivo esorcismo interpretativo è riuscito a minimizzare o a
edulcorare, non si può fare a meno di riconoscere che nella visione di
Nietzsche della volontà di potenza albergano aspetti antidemocratici e
antiegualitari che fanno parte della componente reazionaria del suo pensiero”.
La filosofia di Nietzsche è una filosofia
per spiriti forti che si richiama a Eraclìto, aristocratico per eccellenza, con
i suoi “svegli” e i suoi “dormienti” e che è stata poi pienamente abbracciata
dal Nazismo.
Vita di Nietzsche
Friedrich Wilhelm Nietzsche ( Röcken 1844 – Weimar 1900 ) è stato
un filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco, tra i massimi filosofi e
prosatori di ogni tempo, Nietzsche ebbe un'influenza controversa, ma
indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del Novecento. La sua filosofia,
appartenente al filone delle filosofie della vita, è
considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un
nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un
pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui
esercitata sul pensiero posteriore.
Nietzsche
scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana),
la società moderna, la scienza,
intrise di una profonda lucidità ed avversione alla metafisica,
seppure spesso il filosofo venga accomunato anche all'irrazionalismo, di una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della
parodia, portando anche l'occidente a conoscenza di parte delle filosofie orientali. Nella sua filosofia si distingue una fase
wagneriana, che comprende La
Nascita della Tragedia e
le Considerazioni
inattuali, in cui il filosofo
combatte a fianco di Wagner per
una riforma mitica della cultura tedesca.
Questa
fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo
umano - nella stagione
cosiddetta "illuministica" del suo pensiero -, per culminare infine,
pochi anni prima del crollo nervoso - probabile conseguenza di una patologia neurologica ereditaria - che metterà fine alla sua
attività, nella fase più prominente del suo pensiero (quella della trasvalutazione
dei valori e
del nichilismo attivo, costellata dai concetti di Oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza) che ha il suo apice ed inizio con la pubblicazione
del celeberrimo Così
parlò Zarathustra.
Commento di don Claudio Crescimanno
Dunque la realtà non
ha senso, la vita e la morte non hanno spiegazione e non hanno senso, non si
può cercare destinazione né al pensiero né all’azione, cioè non c’è un punto
di arrivo nel mio pensare e nel mio agire. Questo non senso non può essere
attenuato, e tanto meno risolto, dall’idea che esista qualche cosa fuori di
me che possa dare quel senso, quel significato, quello scopo che io non gli
posso dare.
Nietzsche infatti non dice tanto che Dio non c’è, ma fa
molto di più, si batte per togliere agli uomini l’illusione che ci sia un Dio
o una divinità o un suo surrogato o una sua idea o un suo luogotenente o
altro a cui aggrapparsi per un ingiustificabile bisogno di senso.
Non è un caso che l’originatore di tutto questo sia
Zaratustra, questo fantomatico personaggio dell’antichità (circa 3.000 anni
prima), dai contorni sfumati e fondatore di una religione che ha queste
caratteristiche, e quindi scelto da Nietzsche proprio per questo. Ed è
curioso che per far nascere un uomo nuovo utilizzi un “profeta” così antico.
Lo Zoroastrismo ha queste
caratteristiche:
1.
è una religione
senza Dio, non è una
religione teologica, cioè non si pone domande su Dio, è una religione antropologica,
è un via per l’uomo, non un via per l’uomo verso Dio.
2.
è un satellite
del grande sistema manicheo, in cui il bene e il male sono sullo stesso piano e hanno una funzione
reciproca. È di fatto la visione dell’equilibrio fra l’Apollineo e il
Dionisiaco, tra la ragione e l’istinto, tra il bene e il male, tra la luce è
l’oscurità. Due Spiriti
primi sono il Bene e il Male, la Verità e la Menzogna: ai seguaci del primo
toccherà in sorte la Vita e la Migliore Esistenza mentre i seguaci del
secondo otterranno la Non-Vita e la Peggiore Esistenza.
3.
è la religione della
forza. In esso la casta dei sacerdoti
è la casta dei guerrieri. La casta che custodisce i segreti misterici ed
esoterici della religione e della vita è una casta di sacerdoti guerrieri o
di guerrieri sacerdoti.
Quindi possiamo dire che lo Zoroastrismo si prestava “ad hoc” allo scopo di Nietzsche e alla
dimostrazione della sua tesi.
Ci stiamo avvicinando alla fine di un percorso che ci vede
nel secolo XIX° alla morte di Nietzsche e alla vigilia della realizzazione
sperimentale delle due grandi correnti: la sinistra hegeliana con Marx e la
destra razzista di Nietzsche accomunate, anche se nemiche, dal rifiuto di Dio
e dall’uso della forza delle idee e delle armi.
Siamo cioè alla vigilia della realizzazione pratica di
queste due correnti di pensiero. Abbiamo già evidenziato che i filosofi non
sono dei teorici astratti che lasciano il tempo che trovano, ma influenzano
gli uomini, le loro passioni, le loro strutture e istituzioni e le loro
azioni.
La famosa frase “La filosofia è quella cosa
con la quale e senza la quale il mondo rimane tale e quale” che ricorre
quasi sempre quando si inizia a studiare filosofia a scuola vorrebbe essere
un invito per i “dormienti” a lasciarla perdere per dare agli “svegli” la
possibilità di dominarli [Ndr].
Da questi due pensatori, Marx e Nietzsche, sono venuti i
due grandi sistemi che hanno imperversato e ancora imperversano anche con
nuove forme di violenza i nostri giorni.
Il XX° secolo è dal punto di vista politico e culturale e
per il suo esagerato contributo di sangue, la realizzazione di queste due
ideologie (Marxismo e Nazionalsocialismo) che non possiamo non chiamare
demoniache perché utilizzate a piene mani dal seduttore di sempre che cerca
di realizzare l’inferno già su questa terra [Ndr].
Il pensiero di Nietzsche comunque è un pensiero poderoso, è
la prima grande novità dopo tanta rimasticatura dell’idea illuministica e
idealista che ha imperversato per due secoli. Dal punto di vista storico però
prende un abbaglio impressionante.
Di fatto anche Nietzsche fonda una sua religione, critica
gli altri perché si creano un dio con la D minuscola che sostituisce la
Classe, la Scienza, la Ragione, ecc. ma di fatto lo fa anche lui, perché se
non fosse che deve sostenere una tesi ed avere una visione ideologica della
realtà, non potrebbe non rendersi conto dell’abbaglio storico che ha preso. Nietzsche
infatti sostiene che la religione biblica ebraico cristiana, cioè il sistema
di idee più importante e influente in tutto l’occidente, a da qui in tutto il
mondo, è stato un fattore paralizzante della vita.
Storicamente invece la religione biblica ebraico cristiana
ha cosparso l’Europa e per contagio il resto del mondo, di terreni bonificati
(e relative tecniche), di libri e culture salvati, di macchinari e tecniche
cha hanno dato sviluppi interessanti all’agricoltura, all’artigianato e alle
industrie, di Scuole, di Università e di Ospedali. Mentre la sua visione e
quella del suo amico Marx hanno riempito l’Europa di Gulag, di campi di
concentramento, di processi sommari, di olocausti, di purghe, di deportazioni,
di pulizie etniche, di devastazioni culturali, economiche, politiche,
religiose, ecc.
Quale visione è veramente contro la vita?
“Quasi Deus non daretur” o “Quasi
Deus esset” J. Ratzinger
|
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945, teologo luterano tedesco, protagonista della resistenza al Nazismo) nelle annotazioni
della sua prigionia, ha osservato un giorno che oggi anche il cristiano
dovrebbe vivere “quasi Deus non daretur”
(come se Dio non esistesse). Egli non dovrebbe coinvolgere Dio nelle faccende
della sua vita quotidiana e dovrebbe plasmare la sua vita terrena con totale
responsabilità, senza deleghe. Io, invece vorrei dire proprio il contrario:
oggi. Anche colui per il quale l’esistenza di Dio e il mondo della fede sono
diventati oscuri, dovrebbe vivere praticamente “quasi Deus esset”: vivere cioè come se Dio realmente esistesse.
Vivere sotto la piena sovranità della Verità, la
quale non è un nostro prodotto, ma è nostra signora. Vivere sotto il modello
della Giustizia, che non è qualcosa che possiamo escogitarci a piacere, ma è
un’istanza di cui avvertiamo tutta la forza e che è metro che misura anche noi.
Vivere nella responsabilità di fronte all’amore, che ci attende e ci ama in
prima persona. Vivere avvertendo la pretesa (e la costante e amorevole
presenza) dell’Eterno. Nelle annotazioni della sua prigionia.
Chi, infatti, è attento
all’odierno volgere degli eventi, capisce che questa è l’unica maniera in cui
l’uomo può essere salvato. Dio – Lui solo – è la salvezza dell’uomo. Questa incredibile
verità che per molto tempo ci è sembrata teorica e irraggiungibile, è diventata
la formula più pratica do questa nostra particolare ora storica. E chi, sia
pure forse esitante all’inizio, si rimette a questo arduo e pure inevitabile
“come se” – vivere come se Dio esistesse – si accorgerà sempre di più che
questo “come se” è la vera realtà. La responsabilità che essa sprigiona renderà
allora avveduti della sua forza liberante. E si saprà profondamente e
indistruttibilmente perché, anche oggi, il cristianesimo sia ancora necessario
come il vero e lieto annuncio che salva davvero l’uomo. (tratto da J. Ratzinger
“Dogma e predicazone” ed. Queriniana,
1974)
Ratzinger vs Nietzsche e le “minoranze creative”
Friedrich Nietzsche (1844-1900), considerato
tra i più originali pensatori occidentali di ogni tempo, continua ancora oggi
ad esercitare un'enorme influenza sul pensiero filosofico e non solo. Nietzsche
rientra a pieno titolo nell'evoluzione culturale descritta per comprendere
quale sia stato il percorso storico di distacco dell’uomo dalla religiosità,
anzi probabilmente rappresenta la tappa finale, o se preferiamo, quella in cui
il distacco diventa “l’uccisione di Dio”.
Di quel punto di vista troviamo
conferma, ulteriore arricchimento ed evidenze storicamente più attuali in ciò
che ha scritto Josef Ratzinger, prima da cardinale e poi da Papa.
Ratzinger, divenuto pontefice, cita
Nietzsche, in riferimento alla sessualità, nell’enciclica Deus caritas est. Infatti dopo un'attenta disamina filologica dei
termini che hanno dato origine alla parola amore – eros (amore tra uomo e donna
), agape (amore nel senso più ampio del termine), filia (amore di amicizia) –
Benedetto XVI° si esprime così: “Nella critica al cristianesimo che si è
sviluppata con crescente radicalità a partire dall’illuminismo, questa novità
[la messa in disparte della parola eros, n.d.r.] è stata valutata in modo
assolutamente negativo.
Il cristianesimo, secondo Friedrich
Nietzsche avrebbe dato da bere del veleno all’eros, che pur non morendone ne
avrebbe tratto una spinta a degenerare in vizio [cfr. Jenseits von Gut und
Böse, IV, 168]. Con ciò il filosofo tedesco esprimeva una percezione molto
diffusa: la Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara
la cosa più bella della vita? Non innalza forse cartelli di divieto proprio là
dove la gioia, predisposta per noi dal Creatore, ci offre una felicità che ci
fa pregustare qualcosa di Divino?”.
Dopo aver tratteggiato come l’eros sia
stato concepito nelle epoche passate – come ebbrezza divina o come culto della
fertilità, in una prospettiva principalmente corporea, pur con l’aspettativa di
un contatto con il divino della natura – Benedetto XVI°, sempre nella stessa
enciclica, ci ricorda come esso possa trovare la sua vera grandezza quando la
persona, che in realtà è creatura unitaria, ama con il corpo e,
contemporaneamente, anche con l’anima. Non si ha l’“avvelenamento” della
sessualità ma la sua apertura verso una forma di amore più grande e completa
che può, proprio per questo, aprire l’uomo alla realtà di Dio.
Qualche anno prima, da cardinale,
Ratzinger, affrontando il tema del rapporto dell’uomo contemporaneo con la
religiosità aveva scritto: “...la fede cristiana oggi stenta a raggiungere, con
il suo grande messaggio, gli uomini in Europa... Vedo due cause principali. La
prima è stata introdotta da Nietzsche quando disse: Finché non si percepisce la morale del
cristianesimo come crimine capitale contro la vita, i suoi difensori avranno
sempre gioco facile ” (1).
Il Cristianesimo ha dunque per
Nietzsche un valore assolutamente negativo. Egli nella morale cristiana (da lui
definita "morale dei vinti") vede una sorta di negazione della vita.
Quella cristiana è la religione dei deboli, degli schiavi, di coloro che
rinunciano a vivere nel senso pieno del termine ed individua nella stessa
storia dell'Occidente un lungo processo di decadenza dell'uomo che ha
rinunciato alla vera essenza vitale della natura umana; il vero destino
dell'uomo è invece l'affermazione della propria libertà (volontà di potenza).
Ma è davvero così? Una vita
all’insegna dei valori cristiani è una vita di pura rinuncia? È una vita in cui
non si possono vivere pienamente le potenzialità dell’esistenza? Aderendo al
cristianesimo che “sembra limiti l’uomo in tutto, che guasti la sua gioia di
vivere, che limiti la sua libertà così preziosa e lo conduca non al largo... ma
nell’angustia, nello stretto” (2) non si è più veramente liberi?
Ratzinger ci sorprende perché non è
con argomentazioni teologiche o filosofiche che controbatte le tesi del
filosofo, di estrema attualità in quanto costituiscono oggi un orientamento per
molti e fanno parte del senso comunemente accettato. Infatti, per ciò che
riguarda questa critica più generale al cristianesimo, Nietzsche afferma che
esso può ricevere nuova linfa solo se vi saranno uomini e donne che mostrino
agli altri con il loro esempio che è possibile una vita “in tutta la sua
libertà”, che sperimenta l’amore come apertura alla grandezza della vita.
È questo il compito delle minoranze
creative cioè di quei credenti che in questa contingenza storica accettano la
sfida di essere “lievito”, facendo vedere agli altri come si possa vivere dei
grandi valori della tradizione cristiana, presentando questo modello di vita in
modo convincente e infondendo il coraggio di viverlo.
Probabilmente la Chiesa ha proposto
nel passato modelli di vita che erano più incentrati sul moralismo piuttosto
che sull’incontro con Cristo: solo da questo incontro può prendere forma la
nuova vita del credente. Il vero cristianesimo, anche se impegnativo, è gioioso
perché nella conoscenza di Cristo si è trovata “la perla preziosa (cfr Mt 13,45
sgg.) che dà valore a tutta la vita, facendo sì che tutti gli imperativi
cristiani non siano più zavorre che immobilizzano l’ uomo, ma piuttosto ali che
lo portano in alto” (3). [(1) (2) (3)
J.Ratzinger – M.Pera, “Senza radici”, Mondadori,
Milano, 2004] (Tratto da “Quaderni Cannibali” Ottobre 2010 –
www.donboscoland.it)
La psichiatria in soccorso alla mancanza di senso
Dunque per Nietzsche la realtà non ha
senso, la vita e la morte non hanno spiegazione e non hanno senso, non si può
cercare destinazione né al pensiero né all’azione, cioè non c’è un punto di
arrivo nel mio pensare e nel mio agire. Un’altra drammatica conseguenza di
questo pensiero si è trovato ad affrontare il giovane psichiatra viennese ebreo allievo di Freud, di cui abbiamo già
parlato, Viktor
Emil Frankl , che si è trovato a dover gestire: l’impressionante aumento di suicidi
giovanili dovuti alla mancanza di senso della propria vita.
Lo studio di questo fenomeno lo ha
portato a sviluppare la sua logoterapia che consiste nel ridare un senso alla propria vita, un senso che le faccia accettare la
fatica e la sofferenza nell’affrontare le difficoltà del vivere. In altre
parole Frankl
parte
dall’idea che non è l’uomo che si deve interrogare sul senso della vita, bensì è la vita che pone all’uomo degli interrogativi a
cui deve saper rispondere per condurre una vita di significato assumendosi la responsabilità
della sua esistenza. Il significato ultimo della vita va oltre la comprensione
umana, oltre la ragione dell’uomo; è qualcosa a cui bisogna credere al di là
della propria ragione. Ogni cosa che capita durante la vita ha un significato e
non è opera del caso. Ed è proprio il destino dell’uomo che, recando in sé
la concretezza della vita, lo pone di fronte a delle prove che deve affrontare
in modo da sperimentare possibili valori da realizzare che elevino il suo
spirito interiore.
La sua opera più nota “Uno Psicologo nei Lager”, come abbiamo
già visto, dimostra come lui stesso prigioniero ebreo con altri ha potuto
verificare la forza morale e di conseguenza anche fisica e psichica di chi
nella sua più drammatica situazione di sofferenza e di umiliazioni è riuscito a
dare un senso al suo soffrire e a sopravvivere (in molti casi anche con eroici
atti di aiuto nei confronti dei compagni, vedi padre Kolbe) e chi, non
trovandolo, si è lasciato morire di fame, di stenti, di malattie e di
disperazione.
Una simile situazione la troviamo anche
nella testimonianza di Eugenio Corti
(1921-2014), nel suo ormai più che famoso romanzo autobiografico “Il Cavallo Rosso”, nel quale descrive le
atroci sofferenze dei soldati italiani nella ritirata di Russia e come la forza
di volontà di superare la drammatica situazione ha permesso a molti di sopportare
i fortissimi disagi fisici, psichici e morali incontrati (aiutati anche dalla
straordinaria presenza del cappellano militare Don Gnocchi) e di tornare a casa
in situazioni praticamente impossibili (e al contempo, anche qui, con numerosi atti
eroici per salvare i compagni più deboli) e come invece la disperazione ha
portato molti di loro a lasciarsi andare e morire congelati o addirittura a
suicidarsi con il proprio fucile.
Bibliografia
consigliata:
Eugenio Fizzotti “Ha
senso soffrire?” Ed. CVS
Eugenio Corti "Il Cavallo Rosso" ed. ARES Milano
Quando l’uomo perde Dio – J. Ratzinger
“Quando ci rivolgiamo a Dio, quando ci
rivolgiamo a Lui, noi diventiamo uomini nuovi. All’opposto, là dove il mondo
rifiuta Dio esso diventa un pianeta che esce dalla sua orbita e vaga senza meta
nel nulla cosmico. È una terra non più illuminata dal sole e in cui la vita
stessa va estinguendosi. Quando l’uomo perde Dio non ce la fa più ad essere
giusto, perché ha perso il suo fondamentale riferimento. Noi possiamo essere
giusti e sentirci a posto soltanto se la giustizia, prima di tutto, si realizza
in noi. Se noi siamo perciò retti. Ma siamo retti se corrispondiamo alla verità
del nostro essere. La verità del nostro essere è che Dio ci ha creati e che
Egli è la nostra rettitudine. Non vi può essere giustizia se essa non comincia
nell’uomo. Non vi può essere giustizia se l’uomo rinnega la sua origine divina”.
(tratto da “Omelie romane” 1985
contenute in: “Collaboratori della
verità” di Joseph Ratzinger, ed. San
Paolo)
La logica del potere - J. Ratzinger
Esiste
una particolare forma di esercizio del potere, purtroppo molto diffusa nel
nostro tempo, che si oppone a Dio e che mira a non aver più bisogno di lui,
anzi, a farne semplicemente a meno. L’essenza di tale potere consiste ne
ridurre le cose e le persone a puro “oggetto”, a puro “ruolo” o “funzione”,
facendone così qualcosa di strumentale
rispetto ai propri progetti. Cose e persone non vengono considerate come
realtà vive e di per sé dotate di diritti costitutivi – di fronte alla cui
dignità io devo inchinarmi con rispetto – bensì
trattate come “funzioni”: secondo cioè la logica strumentale della
“macchina”, come se fossero apparati inanimati (anche nel senso di senz’anima per quanto riguarda l’uomo).
In
ultima istanza, questa forma di potere è tale da condurre l’uomo alla morte;
questo potere trascina inesorabilmente colui che se ne serve lungo la china
della morte e di ciò che è morto. La legge che impone agli altri finisce per
disporre anche di lui.
In
questo caso, le parole che Dio ha rivolto ad Adamo – “Se mangerai di quest’albero,
morirai” (cfr. Gn 2, 17) – si realizzano nel loro esatto significato letterale.
E non può essere diversamente, là dove il potere venga concepito come
atteggiamento opposto all’obbedienza. L’uomo non è il signore dell’essere,
anche qualora sia capace di scomporlo in parti più o meno grandi, e poi
rimontarlo insieme quasi fosse una macchina. E neppure l’uomo può vivere contro l’essere: là dove si persuade di
ciò, egli cade in balia della menzogna, cioè del non essere, della pura
apparenza (senza sostanza) e così della morte.
Questo
potere è ricco di attrattive e di influenza (è perfino proposto dal demonio a
Gesù nel deserto). Il suo successo non è che un successo “a termine”, tuttavia
questa sua precarietà può durare a lungo, e abbagliare l’uomo che vive
nell’immediatezza.
PROGRAMMA incontri della quarta tappa:
l'eclissi della ragione
- 4t-1-La reazione a Hegel: Schopenhauer e Kierkegaa...
- 4t-2-La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx
- 4t-3-Positivismo e Darwinismo
- 4t-4-Spiritualismo e Psicanalisi
- 4t-5-Nietzsche: la morte di Dio
- 4t-6-Nietzsche: l'oltreuomo
- 4t-7-La Fenomenologia di Husserl
- 4t-8-Heidegger e l'esistenzialismo
- 4t-9-Idealismo italiano
- 4t-10-Neopositivismo e Pragmatismo americano
- 4t-11-La Scuola di Francoforte e Popper
- 4t-12-L'Ermeneutica di Gadamer e Benedetto XVI








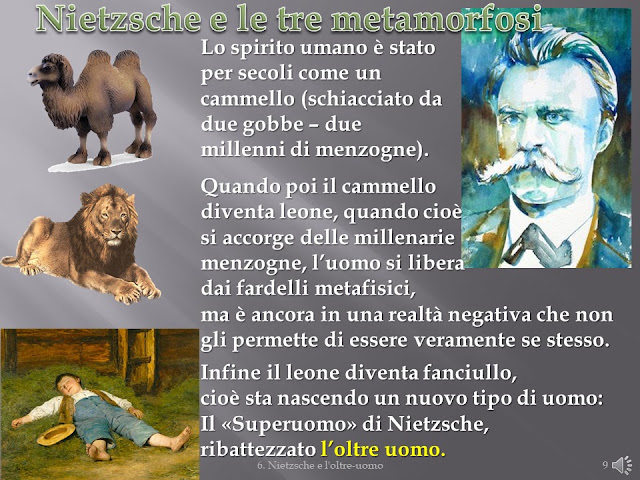

















Nessun commento:
Posta un commento